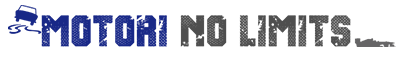Da molti anni trascorro l’agosto in città, a casa. Mi piace camminare nel vuoto doppio dell’estate, con il tempo per osservare ciò che non vedi di norma, la cima dei palazzi, i dettagli di una strada, di un angolo, di un portone. Il mio amico Diego ripete sì, non male, resta da spiegare come mai un sacco di gente preferisce la Sardegna, le Dolomiti, i Caraibi, quei posti lì, mentre è così bello camminare come un pirla nella città deserta. Mi sa che ha ragione, che mi consolo esaltando una realtà migliorabile, parlando di vacanze.
 Però, nel vuoto, appunto, nel silenzio di città, visto che qui parliamo di motori, mi vengono in mente estati lontane, quando proprio in agosto si correva, in Austria soprattutto, e si provava, a Monza ogni anno. Era la vera festa d’estate per noi ragazzini. Il rumore dei dodici cilindri Ferrari come urla trasportate dal vento, sopra le cime degli alberi del parco di Monza. Richiami precisi, come la tromba del sergente Rip Master che elettrizzava Rin Tin Tin. Inforcavamo le nostre bicilette e via, verso l’autodromo, presi da una frenesia meravigliosa. Tutti là, sull’attenti, dove non si poteva entrare, dove riuscivamo a entrare sempre, a furia di impietosire guardiani dal cuore ben più tenero dei loro modi.
Però, nel vuoto, appunto, nel silenzio di città, visto che qui parliamo di motori, mi vengono in mente estati lontane, quando proprio in agosto si correva, in Austria soprattutto, e si provava, a Monza ogni anno. Era la vera festa d’estate per noi ragazzini. Il rumore dei dodici cilindri Ferrari come urla trasportate dal vento, sopra le cime degli alberi del parco di Monza. Richiami precisi, come la tromba del sergente Rip Master che elettrizzava Rin Tin Tin. Inforcavamo le nostre bicilette e via, verso l’autodromo, presi da una frenesia meravigliosa. Tutti là, sull’attenti, dove non si poteva entrare, dove riuscivamo a entrare sempre, a furia di impietosire guardiani dal cuore ben più tenero dei loro modi.
Dentro, con i sandali a calpestare il porfido di un paddock minuscolo a pensarci, con i camion piccoli dei team, i piloti che si cambiavano a due metri, sotto-tuta bianco, tuta, casco in mano, guanti. Le macchine stavano nei garage, i meccanici mangiavano e lavoravano senza sosta, quelli della Ferrari in tuta blu, con il marchio della Shell, credo, sul petto, mentre le tute dei piloti erano di un candore lucente, con la scritta Firestone in rosso quasi sempre. Noi, ritti come marmotte attentissime. Un blocchetto e una penna nelle mani, in attesa dell’autografo. Questi premi arrivavano puntualmente perché non era mica come adesso, non c’era affatto una vera e propria ressa, tanto è vero che persino dei bambini come noi potevano muoversi in una prima fila immaginata, ambita e alla fine raggiunta senza troppa fatica.
![]() Conservo ancora una fotografia di Jochen Rindt, con la dedica “A Giorgo”. Proprio così “Giorgo”, senza una “i”, chissenefrega. E poi un cappellino rosso letteralmente ricoperto di firme. Ci penso, rivedo i volti, altri dettagli di un agosto lontano. Rivedo il ciuffo pettinato all’indietro di Pedro Rodriguez, i baffi chiari di Jo Siffert, il sorriso di Peter Revson, i gesti gentili di Jackie Stewart, lo sguardo di Jacky Ickx. Che poi era, con Rindt, il mio preferito. Franco Varisco, bravissimo fotografo di corse, mi aveva regalato una serie di foto. E con lui giravo tra le macchine a caccia di firme. Ickx, che nel tempo è diventato un caro amico, mi ha confessato dopo vent’anni da quei giorni (era il 1969, poi il 1970) di aver pensato fossi il figlio di Varisco, per dire come è curiosa la vita.
Conservo ancora una fotografia di Jochen Rindt, con la dedica “A Giorgo”. Proprio così “Giorgo”, senza una “i”, chissenefrega. E poi un cappellino rosso letteralmente ricoperto di firme. Ci penso, rivedo i volti, altri dettagli di un agosto lontano. Rivedo il ciuffo pettinato all’indietro di Pedro Rodriguez, i baffi chiari di Jo Siffert, il sorriso di Peter Revson, i gesti gentili di Jackie Stewart, lo sguardo di Jacky Ickx. Che poi era, con Rindt, il mio preferito. Franco Varisco, bravissimo fotografo di corse, mi aveva regalato una serie di foto. E con lui giravo tra le macchine a caccia di firme. Ickx, che nel tempo è diventato un caro amico, mi ha confessato dopo vent’anni da quei giorni (era il 1969, poi il 1970) di aver pensato fossi il figlio di Varisco, per dire come è curiosa la vita.
Ma quale spiaggia, mare, bomboloni, pizza, era quello il massimo della vacanza. Ore di attesa e poi lo sconquasso di un motore che si avvia, prima, seconda, terza, sbraaaaang. Chiudevo gli occhi, la sera, e percorrevo un intero giro di pista riascoltando nella mente ogni staccata. Mettevano le cartoline sulla forcella della bici, i raggi della ruota la pettinavano frullando ed era come avere sotto la sella una belva spaventosa. Pedalando come forsennati, sudando come fossimo al mare, felici di sentirci parte, ma sì, di un mondo speciale.